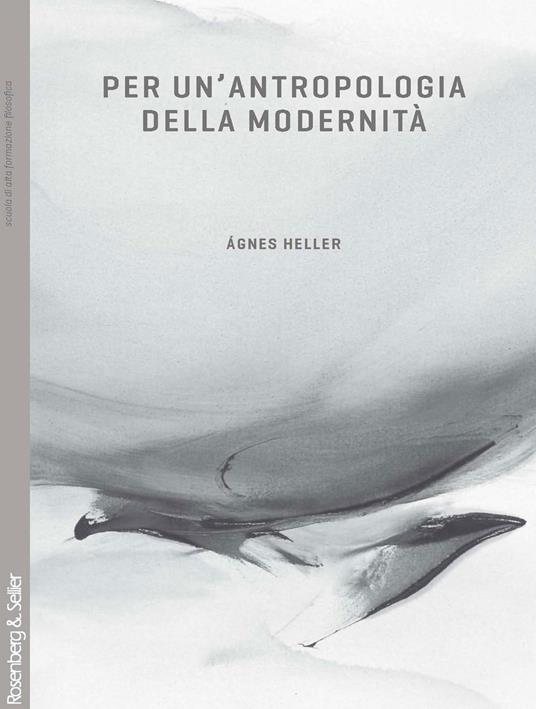Da questo presupposto emerge l’attuale definizione di debunker: non solo colui che sfata i miti e smentisce le bufale, ma un vero e proprio assistente, in grado di fornire al pubblico gli strumenti per riconoscere le notizie false, che segnala quando un media riporta un fatto in modo incompleto (di solito volutamente) e che indirizza verso fonti attendibili chi ha delle lacune su un argomento e rimane confuso da molteplici opinioni contrastanti. A differenza dell’insegnante, il debunker non fornisce le nozioni da immagazzinare, ma aiuta a placare la confusione generata dall’arrivo massiccio di nuove nozioni su cui si è impreparati.
Un esempio rappresentativo di come svolge il proprio lavoro il debunker odierno si può trovare in un articolo della redazione Butac sull’epidemia di Xylella fra gli ulivi pugliesi: «La Xylella è una bufala che si cura con la magia». Il testo è la disamina di un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, in cui si sostiene l’idea che il batterio Xylella fastidiosa non causi la morte degli ulivi. L’autore di Butac non si è cimentato in una risposta a queste affermazioni con un report sulla Xylella ricco di riferimenti dalla letteratura scientifica.
Ha invece evidenziato l’inattendibilità delle fonti utilizzate nell’articolo. Si è poi focalizzato sull’uso fuorviante di termini e concetti scientifici, volutamente utilizzati fuori contesto per rendere autorevoli affermazioni non verificate (o non verificabili). Infine, il debunker ha ricordato ai lettori che, nonostante l’autore dell’articolo sul Fatto Quotidiano sia un affermato ricercatore di genetica, ciò non è sufficiente per ribaltare gli ultimi 150 anni di scoperte in ambito microbiologico.
Informare: una corsa contro il tempo
La confusione che i debunker si prefiggono di risolvere, è soprattutto generata dalla quantità d’informazioni che raggiunge l’individuo, spesso senza che questo le abbia attivamente cercate. L’esigenza di dover produrre sempre più informazione è attribuibile a una rincorsa alla novità. I fattori a monte di questo fenomeno sono molteplici, ma a dare una forte spinta è senz’altro l’obiettivo di far rimanere l’utente il più tempo possibile all’interno del media che sta utilizzando.
Questo comporta che le agenzie di stampa, per mantenere il “ritmo produttivo” di nuove notizie, si ritrovano a ridurre le risorse investite nel fact-checking; di conseguenza, i canali di comunicazione come tv, radio e social non hanno motivo di filtrare quanto è riportato dall’agenzia, in quanto il loro scopo è la capillarità e la viralità, non la profondità e la veridicità della notizia.
Un esempio emblematico di quanto la rincorsa alla novità vada a discapito del fact-checking è quanto è successo nel 2019 (e recentemente) in merito allo sversamento nell’oceano delle acque provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima. Anche in questo caso un’analisi fatta da Butac evidenzia le criticità del modo in cui è stata diffusa la notizia. Nell’analisi si confrontano i titoli allarmanti di diversi media italiani con quanto pubblicato da un’agenzia di stampa britannica.
In entrambi i casi gli articoli si basavano sulle ultime dichiarazioni del ministro dell’ambiente giapponese, ma l’analisi fa notare come l’agenzia britannica si è attenuta alle affermazioni del ministro, senza commentarle e con un uso adeguato del virgolettato. Solamente dall’osservazione dei titoli, si può notare come la stampa italiana abbia traviato quanto è stato detto, aggiungendo dati risalenti al 2018 senza citarne la fonte: un possibile sversamento è divenuto un evento certo, arricchito da dati apparentemente sbalorditivi per aumentare l’engagement. L’articolista di Butac fa risalire questo comportamento della stampa italiana al consapevole intento di sfruttare la paura del pubblico verso l’energia nucleare per rendere la notizia più virale e sensazionalistica possibile.
La scienza è falsificabile, le fake news no
A rendere la figura del debunker quasi essenziale all’interno del panorama informativo contemporaneo, sono anche le allarmanti ricerche (come quella del 2018 di Soroush Vossoughi, Sinan Aral e Deb Roy del Massachusetts Institute of Technology) che hanno messo in luce come le notizie false si propaghino molto più velocemente delle notizie vere. Questo tipo di notizie si diffondono efficacemente nelle echo chamber (camere d’eco) che le aziende che operano online costruiscono sulla base degli interessi dell’utente. Attraverso le tracce digitali che gli utenti lasciano quando visitano un sito, gli algoritmi tendono a personalizzare l’esperienza di navigazione online mostrando le stesse pubblicità, notizie, post, a tutti coloro che hanno tracce simili. Se da una parte questo confinamento degli utenti facilmente suggestionabili in nicchie isolate può sembrare un fatto positivo, dall’altra crea una forte fidelizzazione degli stessi verso le pagine promotrici di fake news. Una fedeltà che in alcuni individui può degenerare in cieca idolatria, in cui l’utente disconosce qualsiasi altra fonte d’informazione e costruisce la propria visione del mondo unicamente sulla base di quanto apprende dalla sua echo chamber.
A proposito dei motivi per cui una persona può arrivare a chiudere i ponti comunicativi con chiunque non sposi la sua visione della realtà si stanno conducendo studi sociologici approfonditi. Ciò che si osserva è il bisogno delle persone di trovare una narrazione che li soddisfi, senza indagare se la narrazione in questione corrisponda ai fatti. Il fenomeno della necessità di una narrazione personale e soddisfacente si è talmente inasprito negli anni da riaprire anche il dibattito filosofico: esiste una realtà oggettiva? La verità è assoluta o relativa? Solo la scienza detiene la verità?
Nel libro Per un’antropologia della modernità, l’autrice Ágnes Heller espone il pensiero di diversi pensatori che nel tempo hanno tentato di dare una risposta a queste domande. Alcuni filosofi dello scorso secolo hanno proposto l’esistenza di diverse tipologie di verità.
In particolare, si è a lungo tentato (e tuttora il dibattito è aperto) di separare le verità non falsificabili, quali ad esempio le verità matematiche, da quelle falsificabili, intendendo con ciò affermazioni vere fintanto che non giunga qualcuno a dichiararle false: è questo, secondo Popper, il carattere proprio delle teorie scientifiche. A questi però si potrebbe aggiungere un terzo tipo verità, anch’essa non falsificabile: la rivelazione religiosa, espressa mediante affermazioni che si impongono di per sé come vere.
Tenendo a mente questa distinzione, è evidente come, se da un lato la scienza moderna fonda la propria veridicità sui risultati algebrici, d’altro canto, ed è questo il punto interessante, il pensiero filosofico vede la specificità delle asserzioni scientifiche nel loro essere affermazioni falsificabili, sempre aperte ad una smentita. Il pensiero che contraddistingue chi crede fermamente alle fake news, invece, si basa solo sull’ultima tipologia di verità sopra descritta: affermazioni rivelate che enunciano una verità senza fornirne ragione.
Una battaglia persa?
Grazie alle riflessioni offerte dal dibattito filosofico, è possibile cogliere come i debunker svolgano un ruolo molto difficile: ricostruire il percorso che ha portato alla diffusione di nuove informazioni, dalla produzione (un articolo scientifico, un evento, una dichiarazione) fino ai post sui social network. Ciò avviene attraverso il confronto fra fonti indipendenti e il consenso di tutti gli interessati sui fatti esposti. In poche parole, di fronte alle novità ne cercano le debolezze e valutano se ne consegua una smentita. E qualora non la trovino, i debunker si occupano anche di valutare se altre smentite sullo stesso argomento siano affidabili (come nell’esempio della Xylella). Questo insieme di pratiche, che hanno preso il nome di fact-checking, spesso mal attecchiscono su chi da molto tempo si affida a fonti d’informazione che propongono le notizie come verità rivelate, finendo, paradossalmente, per rafforzarne la convinzione. Perché la narrazione è più importante dei fatti.
Ad esplicitare questo problema è il meccanismo di condivisione senza revisione su cui si basano le piattaforme social. Le persone, o gli algoritmi, che producono informazioni false, non verificate o non verificabili, hanno due obiettivi: creare un contenuto di forte impatto emotivo (così da spingere l’utente a condividerlo), ma allo stesso tempo credibile (che non invogli l’utente alla revisione). In tal modo si crea una narrazione che può sfruttare molti bias cognitivi – a cui tutti sono soggetti senza eccezioni – per attecchire sulla visione della realtà dello spettatore.
Il meccanismo di condivisione senza revisione è particolarmente diffuso ed efficace perché il cervello umano è euristico, ossia cerca delle connessioni tra l’elemento nuovo e ciò che già conosce, di cui ha già fatto esperienza. Di conseguenza, nel momento in cui un media fornisce una narrazione molto emotiva, a cui è facile che le persone vi associno esperienze personali, quel media si garantisce la diffusione di tale narrazione.
In conclusione è bene ricordare che questi fenomeni non sono mai del tutto eliminabili, proprio perché sfruttano meccanismi intrinseci al cervello umano. Le fake news sono sempre esistite e il debunking non si prefigge di farle scomparire per sempre. Ciò su cui i debunker stanno puntando attualmente è avvisare il pubblico che non ci si può affidare solo alle narrazioni su cui è più facile identificarsi, perché si rischia di diventare manipolabili.
Attraverso la prevenzione, l’attività di debunking persegue l’obiettivo di fornire una conoscenza condivisa che rimanga solida nel tempo, in particolar modo sui temi scientifici. In tal modo è possibile cambiare l’a priori storico su cui si basano le narrazioni: l’esistenza delle streghe non è certo parte del dibattito odierno, perché l’a priori storico costruito sulle conoscenze condivise pone il problema ai margini, mentre in passato l’esistenza delle streghe era al centro delle discussioni religiose, mediche e politiche. L’auspicio è che in futuro, anche grazie ai debunker, sarà possibile lasciare ai margini del dibattito tutto ciò che si discosta dai fatti servendosi di una narrazione fuorviante, e si metteranno al centro le domande sorte dall’arrivo di nuove conoscenze.
Bibliografia
- Iusve Team, Debunking e fake news: due facce della stessa medaglia, Culture digitali, 5 marzo 2020, https://www.culturedigitali.org/debunking-e-fake-news/.
- Á. Heller, Per un’antropologia della modernità, Torino, Rosenberg & Sellier, 2009.
- Quattrociocchi e A. Vicini, Misinformation. Guida alla società della disinformazione e della credulità, Milano, Franco Angeli, 2016.
- Neil, La Xylella è una bufala che si cura con la magia, Butac, 21 giugno 2018, https://www.butac.it/la-xylella-e-una-bufala-che-si-cura-con-la-magia/.
- Maicolengel Butac, L’acqua di Fukushima sversata nel Pacifico, Butac, 11 settembre 2019, https://www.butac.it/lacqua-di-fukushima-sversata-nel-pacifico/.
- Vosoughi, D. Roy, S. Aral, The Spread of True and False News Online, «Science», vol. 359, 2018, n. 6380, pp. 1146-1151, DOI: 10.1126/science.aap9559.

Con il motto: “Andrò a costruire pannelli solari”, fin dalle scuole medie si avvicina alle tematiche ambientali. Dopo aver frequentato un Istituto tecnico biologico a Vicenza, si laurea in Biologia Molecolare e poi in Biologia Evoluzionistica a Padova. Appassionato di saggistica scientifica, si propone ad Atmosphera Lab con l’intento di mettersi alla prova e scrivere di ciò che da sempre muove la sua curiosità: l’ambiente.